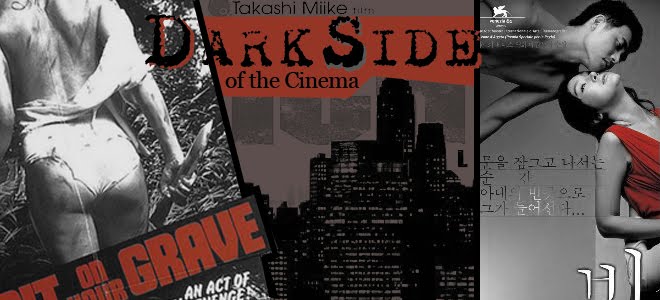Pensavo di aver visto tutto in quel fantastico – ma a volte anche sconcertante – mondo che è il Cinema, ma mi sbagliavo… mi mancava lui… King of the ridiculous… signori e signore, ecco a voi l’unico, l’inarrivabile, l’inimitabile Nick Palumbo! Questo ragazzotto, quasi quarantenne, dal capello molto cotonato penso possa concorrere con ed Ed Wood – un “must” per tutti gli amanti del trash – ed Uwe Boll – un “somaro” e basta per tutti – al premio come peggior regista della storia…
Pensavo di aver visto tutto in quel fantastico – ma a volte anche sconcertante – mondo che è il Cinema, ma mi sbagliavo… mi mancava lui… King of the ridiculous… signori e signore, ecco a voi l’unico, l’inarrivabile, l’inimitabile Nick Palumbo! Questo ragazzotto, quasi quarantenne, dal capello molto cotonato penso possa concorrere con ed Ed Wood – un “must” per tutti gli amanti del trash – ed Uwe Boll – un “somaro” e basta per tutti – al premio come peggior regista della storia…Cari lettori, come avrete già capito, io sono un amante del genere horror e molto spesso mi capita di tuffarmi con mia grande gioia – ma anche con qualche timore a dir la verità – nel vasto panorama del cinema estremo. È così che ho scoperto esecrabili (sotto)generi che mi hanno entusiasmato come il “rape&revenge” o come il genere “cannibal movie”. Ma, in tutto questo mio “frugare” nei bassifondi cinematografici, mi sono sempre, volontariamente, tenuto a distanza dai cosiddetti “shock movies” ovvero quei film creati, ad hoc, solo per dare scandalo e scioccare il povero spettatore che si appresta a visionarli. Oh dio, a me piace la violenza, e apprezzo molto l’emoglobina rossa sullo schermo cinematografico, ma pretendo almeno una (pseudo)trama che mi faccia venire interesse verso quello che sto vedendo… non amo quei film che sono solo una serie di efferatezze che mettono alla prova anche lo stomaco – d’acciaio sicuramente – dello spettatore più navigato. Però ultimamente, più per curiosità che altro, ho deciso di avvicinarmi a questo malsano mondo ed ho iniziato, la mia scalata verso il sadico più estremo, partendo da Murder Set Pieces (Id., 2004) del già citato Nick Palumbo. Risultato di questa mia prima esperienza? Delusione più totale… in tutti i sensi… sotto il profilo cinematografico, credo sia uno dei film più brutti in assoluto… anzi adesso mi toccherà rivalutare altre nefandezze che avevo bollato come inguardabili. Ma anche sotto il profilo del fattore “extreme” non è andata meglio: tutta la violenza presente – ed è veramente tanta, questo si – è stata veramente innocua, e alla fine tutto si è risolto in un gran sbadiglio continuo durato quasi cento interminabili minuti… e tutto questo è colpa del regista nato a Washington D.C., ben coadiuvato dal protagonista principale però, tale Sven Garrett scaricatore di porto mancato, il quale purtroppo per tutti noi si crede il nuovo Jack Nicholson, almeno a vedere la sua interpretazione… ma non basta urinare in piedi per poter assomigliare a Jack “Torrence” Nicholson.
Un fotografo tedesco neonazista si aggira per le strade di Las Vegas. Nel tempo libero abborda prostitute e le tortura a morte, litiga con cassieri neri di videoteche porno e li fucila e, se capita, se la prende con bambine e ragazze per dare sfogo ad un trauma infantile.
Ok, partiamo subito col meritatissimo martirio della pellicola in questione… inizierei subito citando una frase presente nella copertina del dvd italiano: “il più insostenibile horror mai apparso sugli schermi”, mmm… ci deve essere sicuramente un errore di stampa perché la citazione più appropriata per questa “porcheria” filmica è la seguente “il più insostenibile film mai apparso sugli schermi” e, per nostra sfortuna, non per motivi di cosa esso mostra, ma più semplicemente perché la pellicola di Nick Palumbo è veramente inguardabile. Visto che l’ho tirata subito in causa, parliamo della violenza di tale lungometraggio: ok, non posso negarlo, Murder Set Pieces è violentissimo, sporco, cattivo, eccessivo… ma basta tutto questo per definirlo insostenibile? Purtroppo no. Come ho già detto, in diverse recensioni precedenti, se la tensione latita, e qui dire che latita è un eufemismo, anche la scena più “grandguignolesca” risulta ai più sostenibilissima… certo forse non ai più deboli di stomaco ma dubito che essi guardino pellicole del genere, quindi il problema non si pone proprio. Nick Palumbo è solo (in)capace di mettere in mostra una serie di scene sadiche in stile film porno, ovvero senza nessun nesso logico, senza nessun ritmo, senza nessuna tensione appunto. Ma il problema principale si pone anche in questo ambito: la pellicola dovrebbe essere un insieme di immagini iperviolente che dovrebbero fare la gioia dei cultori del cinema estremo e delle sue più disparate ramificazioni, ma alla fine essa non accontenta nessuno neanche sotto questo aspetto. Analizziamo ciò caso per caso. Gli amanti del sesso violento saranno soddisfatti? Non penso proprio… non credo che bastino un paio di scene di “pecorina violenta” per estasiare tali cultori, senza contare che il protagonista, che sembra un coniglio in calore, ha la faccia di uno che sta sodomizzando un tavolo e che ripete frasi ridicole del tipo: “troia, dimmi cosa senti?”. Ma andiamo avanti… gli amanti dello splatter estremo si possono ritenere soddisfatti da Murder Set Pieces ? Ma quando? Mai… esso non è per niente il film più violento mai realizzato come si è (auto)nominato, anzi, potrei citare al momento almeno cinque lungometraggi molto più insostenibili. E per di più esso è talmente ripetitivo e noioso che andrebbe veramente visto a 2x, anche perché tanto non ascoltando i dialoghi – tra i più imbarazzanti da me mai sentiti – per una volta non si perderebbe davvero niente. Ho visto, sul web, parlare di necrofilia… ma fatevi il piacere... possono bastare una scena di “sesso orale” con una testa mozzata – tra l’altro scena copiata da Alta Tensione (Haute Tension, 2003), il cult d’esordio di Alexandre Aja – e una scena in cui una povera crista muore durante l’amplesso – di noia? – per parlare di necrofilia? Non credo proprio. Ma la spudoratezza di coloro che sono coinvolti in questo progetto non si ferma certo qua, essi citano anche il cannibalismo tra le “colpe” della pellicola in questione… what? Certo, vi è una scena in cui, il serial killer si appresta a “papparsi” una delle sue vittime, ma nulla viene mostrato, tranne il suo primo piano – ridicolo a dir poco – mentre si avvicina alla vittima… mentre l’unica scena cannibale, veramente vedibile sullo schermo, che mi ricordo è quella in cui il protagonista si appresta a mangiare dei resti di un cadavere femminile… tra l’altro tali resti sono veramente inguardabili!
Ma il vero problema di Murder Set Pieces è un altro… anzi, in tutta onestà, sono due… il regista e l’attore principale che interpreta il serial killer. Partirei con Nick Palumbo ideatore, e presente in tutte le vari fasi della realizzazione, di tale scempio di dimensioni colossali. Come già detto il film non ha una vera trama ed è solo un susseguirsi di violenza gratuita… inoltre poi ci sono delle situazioni veramente paradossali del tipo che non è possibile che la polizia non riesca a scovare un assassino che uccide indistintamente sia ragazze a caso sia ragazze che lavorano con lui, di giorno, di notte, in casa o in giro e senza il minimo interesse ad occultare le prove… ma il climax dell’idiozia (in)volontaria si raggiunge quando il protagonista uccide a sangue freddo un commesso di un negozio di film porno davanti a testimoni ma neanche questa sconsiderata azione porta, come sarebbe logico, alle più ovvie conseguenze. Il regista parrebbe ispirarsi ad American Psycho (Id., 2000) soprattutto per la rappresentazione del serial killer: narcisista, palestrato, violento, psicotico e con il “piccolissimo” difetto di odiare tutto il genere femminile. Ma purtroppo le similitudini finiscono qua, perché Palumbo predilige assecondare il suo – inutile – istinto dedito al gore più estremo piuttosto che copiare la caratterizzazione dei protagonisti, il tono e le atmosfere della pellicola di Mary Harron… e in fin dei conti anche la citazione della famosa scena della motosega risulta un’insulsa macchietta. A dare una grande mano al regista americano ci pensa Sven Garrett – chiii??? – uno dei peggiori attori da me mai visto su uno schermo cinematografico, il quale offre alla telecamera il suo fisico da adone, ma niente di più. Esso dà il colpo di grazia ad una pellicola già di per sé ignobile. Il serial killer si aggira per lo schermo grugnendo come un maiale in calore con le braccia allargate tanto da assomigliare a Ninetto, il fidanzato di Tatiana, personaggio creato da Bruno Cirilli. Il culmine del trash dell’interpretazione – ??? – dell’attore tedesco si raggiunge con il suo indimenticabile – e chi se lo scorderà mai… – urlo grugnesco nel momento in cui viene scoperta la sua “camera dei giochi” segreta.
Ma parliamo adesso degli aspetti più interessanti che riguardano Murder Set Pieces, i quali ovviamente non hanno nulla a che fare con la pellicola in sé… e come non potrebbe essere così in effetti? Essi riguardano soprattutto due ambiti, da una parte ci sono le leggende nere riguardanti il film di Nick Palumbo e dall’altra tutte le accuse che si è “beccata” questa idiozia su celluloide. Partiamo con le leggende nere che si sono sparse velocemente sulla rete… in primis, parrebbe che parte del cast si sarebbe allontanata dal set incapace di sopportare tutta quella brutalità presente su di esso, ma non è tutto qua ovviamente. Parrebbe che la polizia si sia presentata più volte sul set a causa delle angoscianti urla durante le riprese. Qua il dubbio che mi pongo è il seguente: ma se ad urlare era il protagonista, non è che la polizia si sia allertata semplicemente perché pensava che ci fosse un cinghiale a zampa libera per Las Vegas? Mi sembra la cosa più logica in effetti. Ma andiamo avanti, parrebbe che un produttore sia stato arrestato perché chi doveva stampare la pellicola ha pensato che si trattasse per forza di uno snuff movie. Ok, basta… non ce la faccio più… come avrete notato ad ogni affermazione ho posto davanti un bel parrebbe… ebbene si… queste sono tutte “cazzate” messe in giro, ad hoc, da sua genialità Nick Palumbo per far pubblicità al suo lungometraggio. Bravo… bravo pirla… è il trucco più vecchio del mondo, non avrà pensato veramente che qualcuno ci potesse cascare? Vabbè, tralasciamo che è meglio. Passiamo alle accuse che questa accozzaglia di ignoranza filmica si è tirata addosso… eccole in ordine sparso: razzismo, antisemitismo, misoginia, pedofilia e, per finire in bellezza, bieco sfruttamento di una tragedia nazionale. Mah... vediamo di analizzare un po’… Murder Set Pieces è razzista? Sinceramente non mi ricordo nessuna scena così razzista da creare scandalo, a meno che sentire frasi del tipo “negro del cazzo” – o qualcosa del genere – sia ancora considerato così sconcertante. Murder Set Pieces è antisemita? Non lo so, il protagonista è sicuramente un neonazista ma questo non penso che conti… anche perché più che qualche grugnito in tedesco mentre il protagonista si “pompa” i muscoli col bilanciere o qualche svastica sul muro non mi ricordo altro. Ok, il nonno del protagonista è stato un grande nazista e lui in qualche sporadica occasione lo esalta… ma non penso che possa bastare questo per parlare di antisemitismo. Anche se il buon Nick Palumbo non ci risparmia, anche in questo delicato campo, una delle sue inutili e stupide provocazioni: infatti tra i credits finali, il regista cita tre produttori, rei di aver rinnegato la pellicola, con il nome di tre gerarchi nazisti. Murder Set Pieces è misogino? Si questo si, ma di certo non più di moltissime altre pellicole in cui la donna viene picchiata e seviziata… in pratica ogni “rape&revenge” sulla faccia della terra. Insomma, niente di così sconcertante. Murder Set Pieces istiga alla pedofilia? Congettura, a mio avviso, molto forzata anche in questo caso. Non c’è nulla che istighi alla pedofilia… anche se in effetti il film ha il “pregio” – onestamente non ho ancora deciso se è un pregio o no – di superare un limite che nessuno aveva ancora avuto il coraggio di oltrepassare: l’uccisione, non solo suggerita, come capita spesso, ma in presa di diretta – e anche in maniera molto cruda – di una bambina. Ma veniamo alla chicca finale, summa del genio dell’inimitabile Nick Palumbo… Murder Set Pieces sfrutta, in modo ignobile, una tragedia nazionale? Certo che si. E qui ho detto tutto. Il caro regista americano ha la brillante idea di inserire nella sua pellicola, in modo arbitrario e completamente ingiustificato, scene di repertorio tratte dalla tragedia americana per eccellenza, l’attentato alle torri gemelle… ma perché Nick? Perché?